Di Francesco Amoruso
Scrivo questo pezzo ispirato dall’amatissimo Amleto De Silva, senza il quale non avrei conosciuto la pagina Prugna: Il comico fa la battuta e fa ridere, l’umorista invece ha un fondo di dramma, un tocco di amaro.
Ecco, la risata satirica ha a che fare con l’umore.
Che deve essere totalmente ribaltato.
Come fare satira ai tempi in cui Netanyahu – dopo che ha bloccato per mesi l’accesso agli aiuti umanitari – se ne esce, in risposta alle accuse di aver condotto la popolazione alla fame, che i palestinesi non sono malnutriti, ma semplicemente hanno fatto poca attività fisica?
Leggi certe cose e non riconosci più chi è che sta facendo satira.
La comunità dei nostri rappresentanti, locali e non, offre contenuti così surreali da restringere drasticamente lo spazio della fantasia.
Che puoi scrivere di peggio? Che Netanyahu dovrebbe smetterla di mettere i Palestinesi al tappeto e invitarli a mettere massa alzando qualche bilanciere? Netanyahu palestinian trainer. La satira smaschera il potere e le sue contraddizioni ma quando questo supera ogni satira possibile, il margine di azione offre spazi di denuncia parecchio sottili.
Si pensi come Giorgia Meloni sia stata capace di cavalcare certi trend, trasformando in spot a suo favore un attacco politico prima ancora che satirico. Il rischio è che la critica si trasformi in assist e allora il crinale è di quelli infami.
Poi, ci si mette pure l’algoritmo che censura libero pensiero e creatività. Gli integralisti fanno paura — e Charlie Hebdo ne è la dolorosa testimonianza — ma anche le piattaforme social, con i loro meccanismi di controllo e cancellazione, non scherzano affatto. In questo guazzabuglio, chiunque voglia avvicinarsi alla nobile arte della satira — che come sosteneva Jonathan Swift è «il cavallo di Troia della verità» — ha una responsabilità enorme.
La satira non è solo provocazione, è denuncia, difesa della libertà di pensiero, un esercizio di coraggio che mette a rischio la propria stessa espressione per smuovere le coscienze. Non è solo questione di riso, ma di testa e metodo. Perché ridere del potente va bene, ma è solo l’inizio. Quando si riesce a far salire l’amaro in bocca, l’incazzatura lucida, la presa in giro che diventa presa di contatto col reale, allora la satira assolve davvero il suo compito. Diventa un colpo di frusta che risveglia, che scuote le coscienze, che ristabilisce uno squilibrio necessario nel gioco delle forze tra chi domina e chi subisce.
La risata è quella dianoetica, cioè che nasce non dall’istinto, ma dall’intelligenza. Una risata che pensa, che analizza, che non si accontenta del grottesco ma ne svela i meccanismi. Non è la risata dell’intrattenimento, ma della consapevolezza. Platone riconosceva che esiste una forma di riso capace di stimolare il pensiero e non solo di distrarre.
È questa risata che la satira dovrebbe inseguire: che apra la mente, fisicamente, letteralmente, che faccia sanguinare, deve dare male, malissimo; non deve curare, deve invitare alla cura. Di sé poi degli altri.
La satira non rincorre il consenso, ma lo disintegra. E farlo ai tempi dei social dove tutto si misura sul consenso e sulle logiche delle diverse piattaforme, capirete il guaio. Per questo la satira ha bisogno che il pubblico la scopra, che la studi, e che comprenda che se si sente offeso, è un buon segnale: la satira non è fatta per proteggere le sensibilità, ma per graffiare le coscienze.
A Napoli, si dice che chi s’offende è ferente e solitamente i detti del popolo non sbagliano.
Ma se ci si libera in una una bella risata la puzza resta addosso ai potenti.
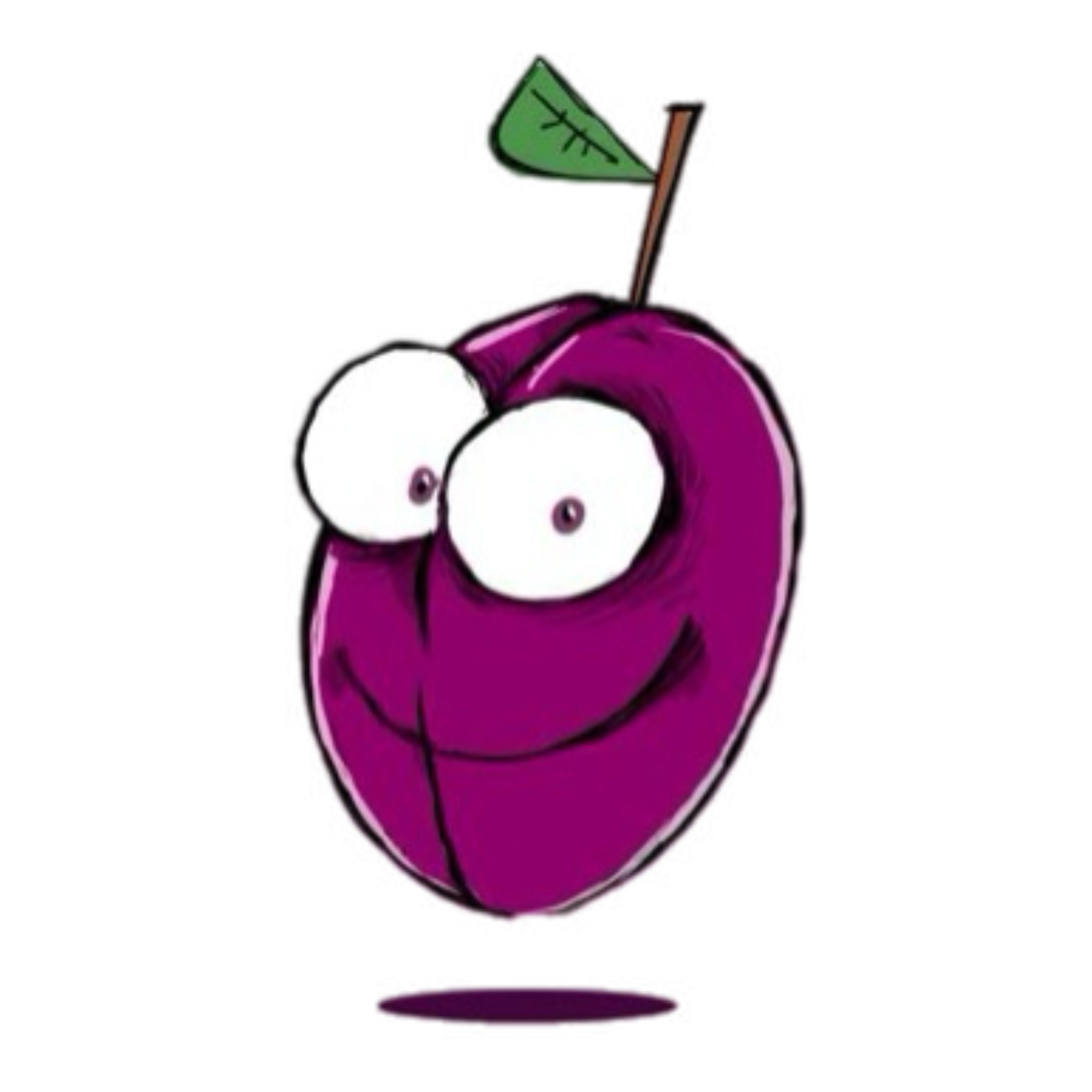
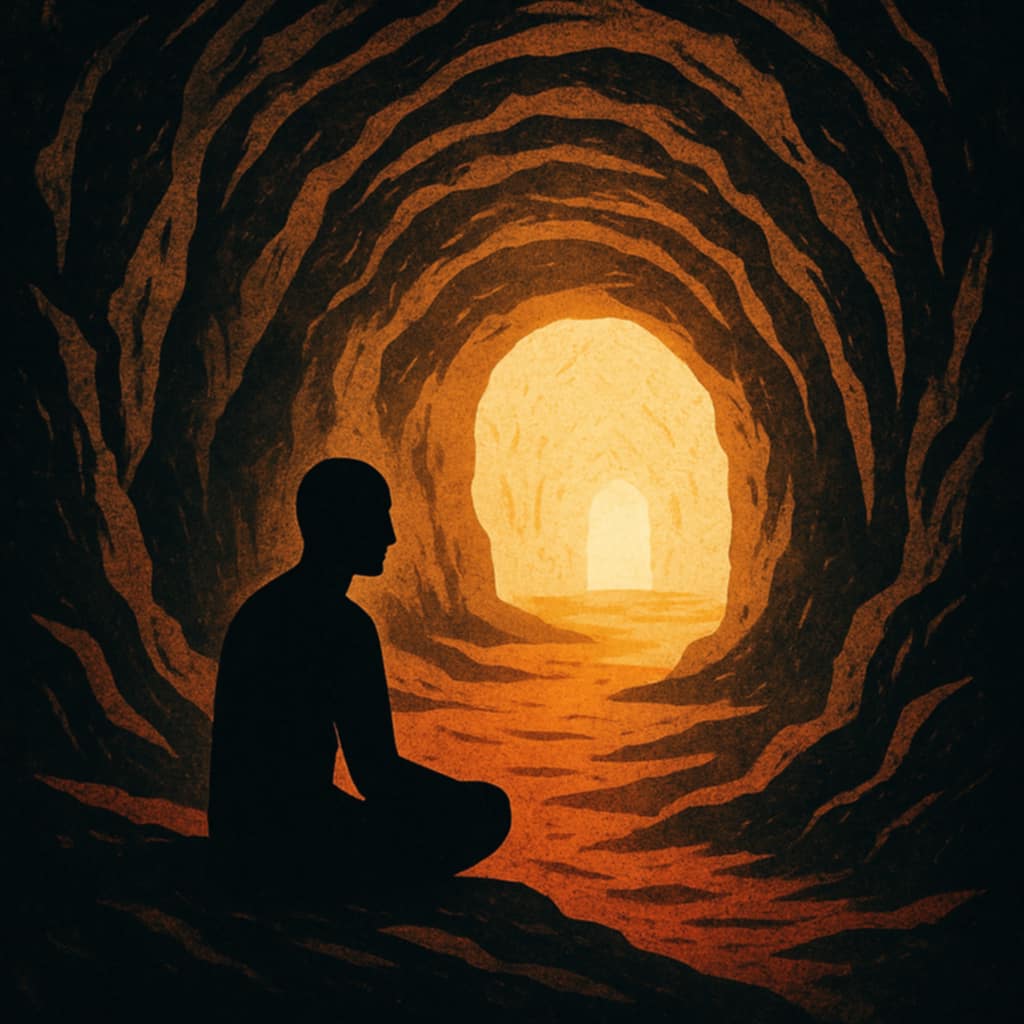
Lascia un commento