Di Emiliano Di Peppe
Origini antiche: Grecia e Roma, dove tutto ha inizio
La satira nasce prima ancora che la si chiami così. Nella Grecia classica, la comicità aveva già una funzione critica e sociale. Aristofane (V sec. a.C.) scrive commedie come Le Nuvole, Lisistrata, Gli Uccelli, dove prende di mira filosofi, politici, istituzioni e costumi con una libertà che oggi farebbe rabbrividire qualunque ufficio stampa.
Ma è a Roma che la satira prende la sua forma definitiva come genere letterario autonomo. Il primo a praticarla fu Lucilio (II sec. a.C.), ma i due massimi esponenti furono Orazio e Giovenale.
Orazio scrisse una satira più riflessiva, moraleggiante, elegante, mentre Giovenale fu il primo a usare la satira come una clava: denunciò la corruzione dell’élite romana, la decadenza dei costumi e il servilismo dell’uomo moderno, con uno stile crudo e spietato.
Il Medioevo: la satira sopravvive mascherata
Nel Medioevo la satira entra in crisi: la Chiesa esercita un controllo quasi assoluto sulla cultura e sul pensiero. Tuttavia, la satira sopravvive nei margini, affidandosi a giullari, trovatori e letteratura popolare. Le “invettive” contro il clero o la nobiltà circolano sotto forma di componimenti anonimi, favole animali e filastrocche.
In ambito ecclesiastico, alcuni autori usano l’allegoria e la parodia per criticare la corruzione interna: ne è esempio “Il Roman de Fauvel”, satira politica e clericale in versi del XIV secolo. Anche Dante Alighieri, pur nel tono solenne della Divina Commedia, riserva molte “stoccate” satiriche a papi, imperatori e letterati suoi contemporanei.
Il Rinascimento: l’esplosione dell’irriverenza
Il Rinascimento, con la riscoperta dei classici e la maggiore libertà intellettuale, segna una rinascita della satira. In Italia brilla la figura di Pietro Aretino, autore feroce, considerato da molti il primo “giornalista” moderno.
Chiamato “il flagello dei principi”, Aretino colpiva con violenza i potenti del tempo attraverso lettere, dialoghi licenziosi e scritti satirici. Nessuno era al sicuro dalla sua lingua velenosa: papi, cardinali, cortigiane e artisti. La sua forza stava nella libertà assoluta e nell’assenza di paura.
In Europa, comincia a prendere forma anche la satira visiva, grazie alle incisioni e alla stampa. In Germania, Sebastian Brant scrive La nave dei folli (1494), una critica alla stupidità collettiva che influenzerà profondamente la cultura satirica successiva.
L’Illuminismo: la ragione diventa sarcasmo
Nel XVIII secolo, la satira assume un tono illuminato: la ragione si allea con il sarcasmo per smascherare l’ignoranza, l’autoritarismo e l’oscurantismo religioso.
Jonathan Swift, autore irlandese, è uno dei massimi esponenti della satira moderna. Il suo capolavoro I viaggi di Gulliver è molto più di una favola d’avventura: è una critica feroce alla politica inglese, all’orgoglio umano e alle assurdità della società. Ma è con Una modesta proposta (1729) che tocca l’apice: Swift suggerisce, con tono freddamente razionale, di risolvere la fame in Irlanda cucinando i figli dei poveri. Satira pura, grottesca, geniale.
Altro gigante fu Voltaire, che con Candido ridicolizzò l’ottimismo filosofico di Leibniz e la religione organizzata, aprendo la strada alla satira filosofica e politica moderna.
L’Ottocento: la satira si stampa e si disegna
Con la rivoluzione industriale e la diffusione della stampa, la satira esplode nei giornali. In Inghilterra nasce “Punch” (1841), una delle prime riviste satiriche illustrate, che darà origine al termine “cartoon” in senso moderno.
In Francia nascono Le Charivari e più tardi L’Assiette au Beurre: le vignette di Honoré Daumier, in particolare, diventano un simbolo di satira visiva anti-borghese e anti-monarchica.
In Italia, Carlo Collodi (l’autore di Pinocchio) fu anche un prolifico scrittore satirico e collaborò con giornali che deridevano la società del Risorgimento. Più tardi, Il Becco Giallo (1924-1926) sfiderà il regime fascista con vignette caustiche, prima di essere messo a tacere dalla censura.
Il Novecento: la satira tra resistenza, fumetto e televisione
Nel Novecento la satira assume forme nuove: romanzo, vignetta, teatro, cinema e, infine, televisione.
In Italia, Giovannino Guareschi crea i personaggi di Don Camillo e Peppone, che diventano un modo ironico per raccontare le contraddizioni di un’Italia divisa tra Chiesa e comunismo.
Con la TV, la satira raggiunge un pubblico di massa: nascono programmi satirici come Drive In, Striscia la Notizia, Le Iene, spesso al confine tra denuncia sociale e intrattenimento.
Sulle pagine dei giornali italiani brillano firme come Giorgio Forattini, Altan, ElleKappa, Vauro, capaci di sintetizzare l’assurdità del potere in pochi tratti e poche parole.
Nel mondo, la satira cinematografica esplode con Charlie Chaplin (Il grande dittatore), e poi con Stanley Kubrick (Il Dottor Stranamore), mentre la satira televisiva si afferma con programmi come Saturday Night Live e The Daily Show.
Il XXI secolo: tra social, censura e rinascita digitale
Nel nuovo millennio, la satira trova un terreno fertile nei social network: meme, video brevi, vignette virali diventano nuovi strumenti di dissacrazione. Ma il web è anche un luogo pericoloso:
la libertà satirica entra in conflitto con nuove forme di censura, autocensura, linciaggi digitali e polarizzazione.
La tragedia di Charlie Hebdo (2015) in Francia – con l’uccisione di 12 persone da parte di fondamentalisti islamici – ha scosso l’Europa, ricordando a tutti che la satira può uccidere e può essere uccisa, proprio perché dice ciò che nessun altro osa dire.
Oggi, la satira è ovunque: nei podcast, nei monologhi da stand-up comedy, nelle vignette pubblicate su Instagram. Ma la sua missione non è cambiata: demistificare il potere, ridicolizzare la propaganda, dare voce a chi non può parlare, accendere la mente attraverso il riso.
Conclusione: perché la satira è ancora indispensabile
In un’epoca in cui tutto è comunicazione e ogni potere si traveste da “vicino di casa”, la satira resta uno degli ultimi bastioni della verità disarmata.
Non è neutrale, non è gentile, non è accomodante. Ma è necessaria.
Perché dove c’è potere, ci sarà sempre qualcuno che proverà a prenderlo in giro.
E finché ci sarà qualcuno che riderà – o si arrabbierà – quella sarà la misura esatta della libertà.
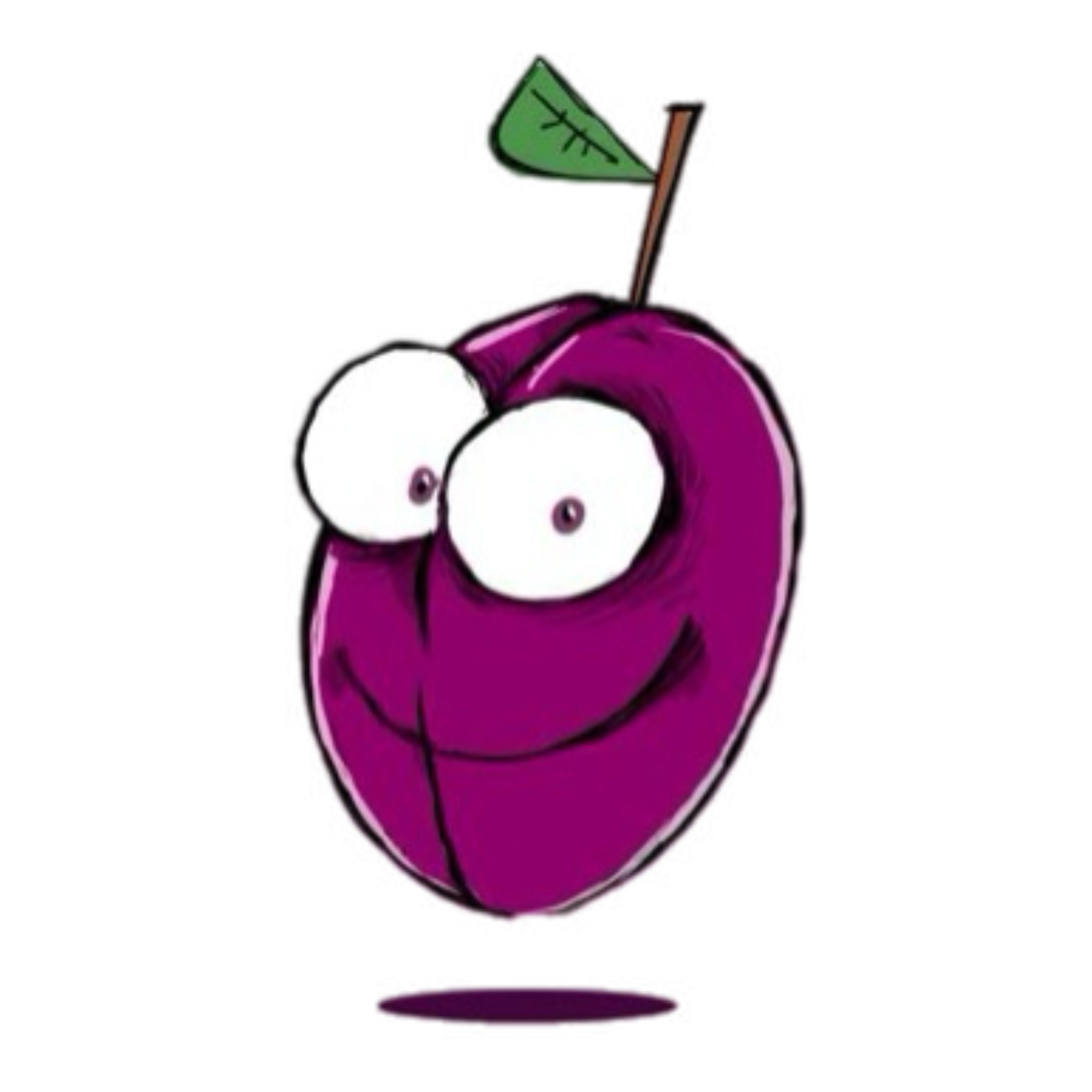

Lascia un commento